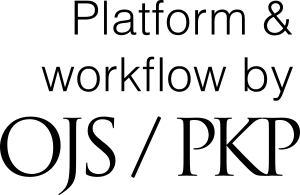DIRITTO ALLA FELICITÀ E BENE COMUNE
DOI:
https://doi.org/10.29327/1163602.7-56Resumo
Nel preambolo della Dichiarazione delle colonie inglesi d’America, firmata a Filadelfia nel 1776, la ricerca della felicità viene catalogata tra i “diritti inalienabili” dell’uomo. In realtà questa idea americana non era del tutto originale, essendo la felicità già stata legata al concetto di diritto attraverso le vicende della meno nota rivoluzione corsa (1730-1769). Peraltro quest’ultima non sembra essere l’unica matrice della Dichiarazione americana. Thomas Jefferson, colui che la scrisse, si ispirò infatti – pur differenziandola negli elementi chiave – anche alla Dichiarazione dei diritti della Virginia redatta, soltanto un mese prima, dall’amico George Mason. Successivamente l’idea di felicità – passando anche dall’opera di Gaetano Filangieri – tornò alla ribalta attraverso la rivoluzione francese del 1789 che, attraverso la formula della “felicità di tutti”, intendeva ribadire – sempre nel suo preambolo – la libera iniziativa dei singoli individui. Al contrario la Costituzione giacobina del 1793 – di ispirazione roussoniana e dal carattere fortemente antindividualistico – introdusse, nel suo primo articolo, la diversa formula della “felicità comune”: lo Stato si trasformò da garante a promotore; e la felicità, da eventualità riservata alla sfera privata, mutò in un vero e proprio dovere. L’odierna tutela internazionale dei diritti inviolabili dell’uomo, pur non prevedendo espressamente il concetto della felicità ha finito – forse proprio per questo motivo – per dilatarne gli orizzonti. Sicché la questione sembra essere tornata di grande attualità, poiché il tema viene considerato uno dei pilastri su cui poter costruire le future politiche amministrative e costituzionali. L’ambizione del mio intervento – che intende indagare la, vera o solo presunta, giuridicità del concetto di felicità – è quella di analizzare – attraverso una metodologia storico-teoretica – la differenza tra i bisogni individuali e la coesistenza, al fine di cogliere alcune insidiose storture che rischiano di contaminare il bene comune, inteso come ricerca in comune del bene, minando ogni criterio di razionalità classica per fare posto a quella che il filosofo della politica Danilo Castellano definisce una “libertà senza criteri”.